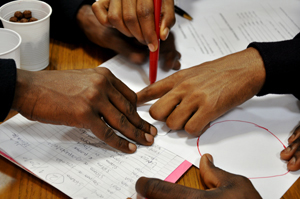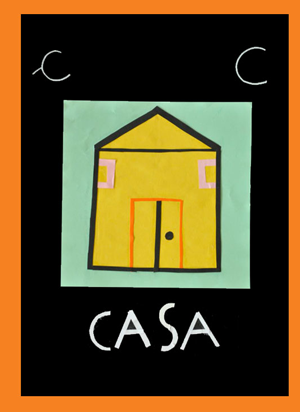Una scuola di italiano si deve fare strumento conviviale per la costruzione di una società della convivenza e della convivialità. Ivan Illich definisce una società conviviale “una società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo strumento (in questo caso la scuola) per realizzare le proprie intenzioni.” Una scuola di italiano rappresenta un luogo e un tempo dove sperimentare una ricerca e un metodo di incontro e riconoscimento reciproco con l’altro. I migranti e i rifugiati, come qualsiasi persona strappata alla propria cultura, volontariamente o meno, pagano un alto prezzo e soffrono di un disagio causato dal disorientamento nostalgico, dalla perdita della casa, dalla crisi della presenza, dai traumi subiti, dal mancato riconoscimento dei propri diritti, dal faticoso e lento adattamento al nuovo contesto di vita. Nello stesso tempo l’arrivo in un paese straniero è anche denso di vitalità, di desideri, di nuove opportunità che si aprono. Una scuola di italiano deve farsi opportunità da cui ripartire per sciogliere la contraddizione di essere entrati a far parte di un nuovo contesto ma di non farne del tutto parte. Nell’incontro con l’altro non ci può essere nessuna predeterminazione perché ogni incontro è unico e diverso essendo diverse e irripetibili le persone al di là dell’etichetta. Ciò che caratterizza l’incontro a scuola è il reciproco non sapere dell’altro: l’altro mi è sconosciuto e mi appare diverso, ma lo stesso accade a lui. In questo senso si è reciprocamente stranieri. Allora una scuola di italiano può rappresentare una soglia di ingresso al nuovo contesto di vita dove, entrambi, il maestro e lo studente straniero, possono trovare un tempo e uno spazio di resilienza per dire in modo elementare e personale: eccoci qui, io sono… L’essere insieme prima del dover essere. Questo è il principio di un percorso comune di conoscenza e scoperta.
“Io sono un uomo invisibile semplicemente perché la gente si rifiuta di vedermi: capito? Come le teste prive di corpo che qualche volta si vedono nei baracconi da fiera, io mi trovo circondato da specchi deformanti di durissimo vetro. Quando gli altri si avvicinano, vedono solo quel che mi sta intorno, o se stessi, o delle invenzioni della loro fantasia, ogni e qualsiasi cosa, insomma, tranne me”.
(Ralph Ellison)
Per ambiente-contesto consideriamo sia lo spazio fisico nel quale ci troviamo ad operare sia l’ambiente relazionale, il clima emotivo che si sviluppa all’interno di un gruppo. Occorre tenere presente che queste dimensioni (fisico/spaziale e emotivo/relazionale) s’influenzano vicendevolmente in modo significativo. Entrambe vanno costruite con estrema cura e attenzione e sono fondamentali per il processo dei singoli individui.
L’ambiente deve essere “tondo”, favorire la circolazione delle idee, la possibilità del fare in prima persona, il passaggio e la realizzazione delle esperienze. Tutto deve parlare di questo: dall’arredo, ai materiali e al modo di prenderli e servirsene, dalla disposizione dei partecipanti, alla postura e all’approccio di chi fa le proposte.
Lo spazio fisico deve essere neutro, ma non anonimo. Ciò significa che deve essere arredato con semplicità e sobrietà, ma al tempo stesso trasmettere accoglienza e calore. Anche un’aula scolastica o di formazione può essere attrezzata in tal senso, a volte basta cambiare la disposizione dei banchi, mettere una tenda e una pianta, togliere dal muro tutto ciò che non riguarda quel gruppo in quel preciso momento (cartine geografiche, copie di stampe d’arte ingiallite, ecc). Le sedie che accolgono il gruppo sono in numero esatto e invariabilmente disposte in cerchio. La strutturazione dell’arredamento può cambiare nel corso delle attività poiché lo spazio è esso stesso strumento didattico e può cambiare con lo svolgersi delle attività. Lo spazio vuoto ma accogliente si presta bene per raccogliere le tracce (gli elaborati e le esperienze) del percorso del gruppo: testi, elaborati grafici, ecc. È cura del formatore/insegnante disporre le tracce nello spazio in maniera che ciascuno ne abbia una buona restituzione anche dal punto di vista visivo/estetico. Ogni persona entrandovi vi si riconoscerà andando a sviluppare un senso di appartenenza a quell’ambiente, a quel gruppo. I materiali devono essere esposti e alla portata di tutti. L’ambiente deve essere leggibile, ovvero già ad un primo sguardo le persone devono poter intuire e comprendere quali attività vi sono previste e come orientarsi nello spazio. La sala (o aula) viene attrezzata ad angoli: vi possono eventualmente essere un angolo caffè, un angolo con la panoplia per gli strumenti e i materiali dell’attività manuale, un angolo con materiali da consultazione, una parete che resta vuota come lavagna e altri a seconda dei gruppi e delle attività da svolgersi. Dal punto di vista del contesto relazionale è necessario costruire un ambiente in cui il giudizio sia meno scontato, immediato e stereotipato rispetto a quello che incontriamo ogni giorno nella nostra vita sociale. Tutti i contesti in cui ci si stupisce, in cui si può apparire agli altri un po’ diversi da come gli altri ci immaginano di solito, sono luoghi a nostro avviso preziosi. Servono ambienti che possano sospendere il giudizio e consentire alle persone di mettersi in gioco. Chi offre formazione non fa altro che essere reciproco a chi in quel momento ascolta e riceve, garante di quella circolarità che costruisce contemporaneamente e parallelamente il senso di presenza dei singoli e il consolidarsi del gruppo in quanto tale. Queste considerazioni sull’ambiente sono alla base di qualsiasi esperienza formativa, sia un percorso di un anno che di poche ore.